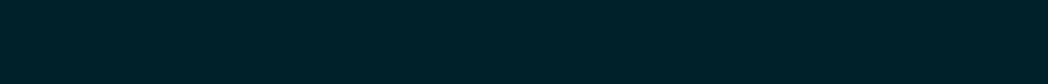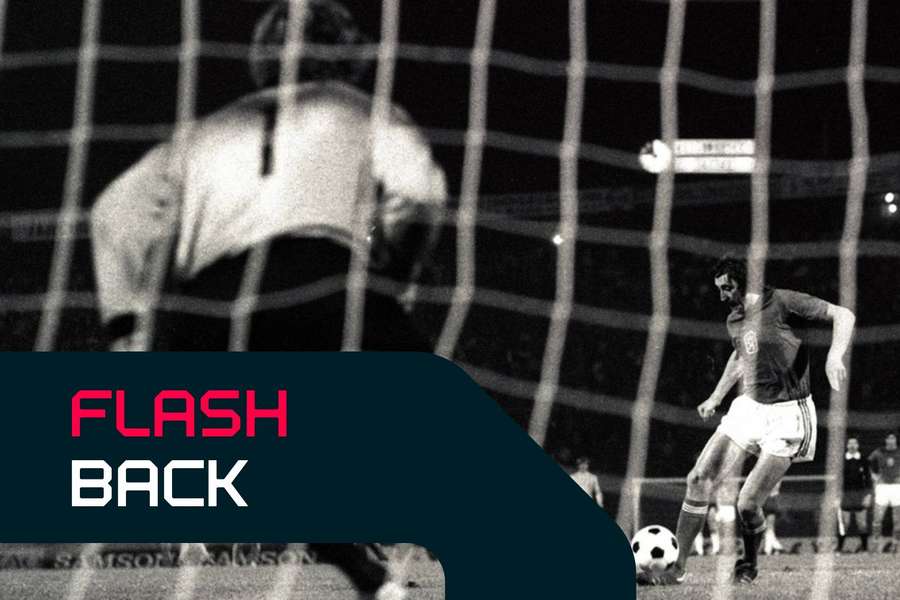I calci di rigore sono stati introdotti nel calcio sono nel 1970 e uno dei principali motivi che hanno portato alla loro introduzione risale 57 anni fa (al 5 giugno 1968) e ha ache vedere con la storia della nostra Nazionale.
Prima dei calci di rigore: tempi supplementari, replay e lanci di monetine
Prima che i calci di rigore diventassero lo "spareggio" per eccellenza, il calcio aveva un mosaico di soluzioni per risolvere le partite finite in parità, nessuna delle quali era del tutto soddisfacente.
Nelle competizioni a eliminazione diretta, le partite che finivano in parità dopo i tempi supplementari dovevano spesso essere rigiocate in un'altra giornata. Questo sistema era complicato dal punto di vista logistico e, nei tornei a calendario serrato, semplicemente impraticabile.
In alcune competizioni, soprattutto nei tornei internazionali con tempi limitati, si ricorreva a metodi alternativi. Se i tempi supplementari non erano decisivi, si ricorreva al sorteggio o al lancio di una moneta come extrema ratio.
L'esempio più famoso si verificò agli Europei del 1968, quando Italia e Unione Sovietica conclusero la loro semifinale sullo 0-0 dopo 120 minuti. Senza gol e senza replay, il lancio di una monetina decise la qualificazione dell'Italia: una decisione che non piacque né ai tifosi né ai giocatori.
Anche la finale però non riuscì a individuare un vincitore nei 120 minuti di gioco. L'Italia affrontò la Jugoslavia a Roma e la partita finì 1-1 dopo i tempi supplementari. Il regolamento prevedeva che la finale venisse interamente rigiocata. Due giorni dopo, le squadre si incontrarono di nuovo, questa volta con l'Italia che vinse per 2-0 e conquistò il suo primo titolo continentale.

La semifinale e la finale del Campionato Europeo 1968 furono i momenti in cui divenne improvvisamente chiara la necessità di un metodo più decisivo e basato sulle abilità.
Quel momento surreale evidenziò la mancanza nel calcio di un vero e proprio spareggio immediato e mise le basi per l'introduzione dei calci di rigore, una soluzione che da allora ha suscitato celebrazioni e polemiche.
L'introduzione dei calci di rigore
L'idea di decidere una partita attraverso una serie di calci di rigore fu proposta più volte già prima di EURO 1968, ma fu solo nel 1970 che il concetto fu adottato ufficialmente.
L'uomo a cui viene spesso attribuito il merito di aver sviluppato il formato moderno dei calci di rigore è l'arbitro tedesco Karl Wald, che propose l'idea alla federazione calcistica bavarese nel 1970. L'idea si diffuse rapidamente nelle competizioni nazionali e fu presto testata nelle partite internazionali.
La UEFA introdusse i tiri di rigore nelle competizioni europee a partire dalla stagione 1970/71. La prima partita ufficiale di alto livello a essere decisa dai calci di rigore fu, nel settembre 1970, quella tra l'Honved e l'Aberdeen, nella Coppa delle Coppe.
La FIFA adottò l'introduzione dei calci di rigore poco dopo. Il primo grande torneo internazionale a prevedere i calci di rigore fu il Campionato europeo del 1976.
La finale del torneo tra Cecoslovacchia e Germania Ovest si concluse proprio ai rigori, con il famoso gol di Antonin Panenka, un momento divenuto leggendario.
Il fatto che sia stato uno dei primi rigori importanti rende il gol di Panenka ancora più leggendario.
Momenti di gloria e di dolore: i rigori più famosi
Da quando sono stati introdotti, i calci di rigore hanno regalato alcuni dei momenti più indimenticabili ed emozionanti della storia del calcio. Da sconvolgenti vittorie a cocenti sconfitte tutte rimaste impresse nel folklore di questo sport.
Finale della Coppa del Mondo 1994: Brasile-Italia
Una delle serie di rigori più iconiche è stata quella con cui si è conclusa la Coppa del Mondo del 1994. La finale di Pasadena fu la prima finale di Coppa del Mondo a essere decisa dai calci di rigore. Dopo un pareggio senza reti, il Brasile trionfò per 3-2 dagli undici metri.
L'immagine più significativa si ebbe quando Roberto Baggio, la stella dell'Italia, tirò l'ultimo rigore oltre la traversa. Il suo errore divenne un simbolo della natura crudele dei calci di rigore: un calcio può definire o distruggere una carriera.
Finale di Champions League 2005: Liverpool vs. Milan
Dopo aver rimontato dal 3-0 in quello che è diventato noto come il "miracolo di Istanbul", il Liverpool ha forzato i tempi supplementari e alla fine ha battuto il Milan per 3-2 in una drammatica serie di rigori.
Fu un finale da favola che elevò la leggenda del club red e cementò lo status degli shootout come palcoscenico della mitologia calcistica.
I calci di rigore e il loro futuro
Nonostante questi momenti memorabili, i calci di rigore restano controversi.
I critici sostengono che riduce uno sport di squadra a una serie di duelli individuali che non riflettono la prestazione complessiva. Sulla sponda opposta c'è chi ritiene che sia una prova di coraggio e di abilità sotto pressione.
Sono state avanzate proposte di alternative, come golden goal, tempi supplementari prolungati o persino algoritmi statistici, ma nessuna ha sostituito la drammaticità e la chiarezza che i rigori offrono.
In definitiva, sebbene i calci di rigore non siano mai stati del tutto equi, sono diventati una parte indissolubile del calcio moderno.
Che si sbirci tra le dita o che si trattenga il fiato sugli spalti, una cosa rimane certa: nessun altro momento del gioco cattura così perfettamente il sottile divario tra agonia ed estasi.